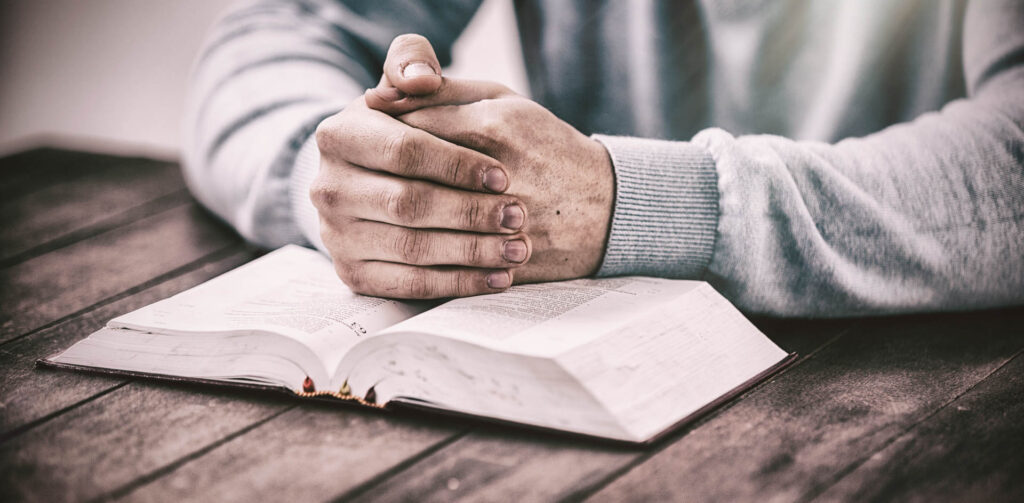
Il 25 novembre 2019 s’è tenuto all’Università della Svizzera Italiana il dibattito dal titolo Individualismo e religione nella Scuola Austriaca, organizzato dall’Istituto Liberale con l’intervento dell’associazione studentesca LPU (Law and Politics in USI) e Students For Liberty Svizzera Italiana. L’incontro ha avuto come tema il rapporto tra l’individualismo sotteso al liberalismo di matrice austriaca e la spiritualità. Un argomento sempre più toccante nel mondo di oggi, scisso tra globalizzazione e secolarizzazione, nel confronto tra l’atomizzazione degli uomini e il personalismo cristiano.

Apre la serata Carlo Lottieri, Professore alla Facoltà di Teologia di Lugano e all’Università di Verona, nonché presidente del comitato dell’Istituto Liberale sezione ticinese. Viene sottolineata l’importanza nel mondo odierno della ricerca del Prof. Cubeddu, che si è occupato di autori liberali come Hayek e autori meno liberali come Leo Strauss, ma non per questo meno interessanti per chiunque voglia approfondire il pensiero liberale. Nel libro Individualismo e religione nella Scuola Austriaca presentato dall’autore, ci si appresta a descrivere l’incisività dell’individualismo metodologico su vari, e per certi versi più profondi, ambiti del vivere umano, fino alle domande sul senso della vita e sul rapporto con la propria spiritualità.

Prende dunque la parola Raimondo Cubeddu, presentando le prime testimonianze dal mondo cattolico, da parte del gesuita A. J. Peters, su come il lavoro innovativo di Menger avrebbe rappresentato una visione laica del mondo. Proprio dall’insoddisfazione di questa interpretazione nasce il libro di Cubeddu, che vuole frapporsi tra la tendenza alla “cattolicizzazione” del liberalismo individualista e il totale rigetto della religione da parte dei sostenitori della Scuola Austriaca. Infatti, sebbene svariati autori, tra cui Mises nel Socialismo, imputassero proprio alla religiosità cristiana le radici del pensiero socialista, lo stesso Menger imputava la tendenza al dirigismo statale al razionalismo asettico e scientifico con cui Adam Smith aveva pensato i rapporti economici in società. La radice degli errori di quest’ultimo, si scrive nell’introduzione dei Principi di economia, è la sua teoria del valore oggettivo; sarà Böhm-Bawerk ad affermare per primo come questo cul-de-sac in cui la teoria economica è stata gettata non lascerà altra logica conclusione che lo scivolamento nel pensiero di Marx.

Menger, continua Cubeddu, affonda i suoi errori più in profondità, in un’errata teoria dello scambio brevettata da Adam Smith. Gli uomini formerebbero il mercato e, di lì, le istituzioni sociali, per un’innata tendenza naturale alla cooperazione. La Scuola Austriaca tenta un’analisi fenomenologica degli scambi di mercato e, grazie alla teoria del valore soggettivo, giunge a scoprire che le transazioni avvengono solamente quando due individui riescono ad accordare le proprie personali preferenze. Queste intuizioni fecero capire a Mises e Hayek che la mancanza di un fondamento filosofico solido della teoria economica di Smith, una mancanza di un’adeguata prasseologia, erano il motivo della difficoltà per la maggioranza socialista dell’accademia inglese di riconsiderare la tradizione di Fergusson, Mandeville, Hume. La teoria del valore-lavoro si prefigurava come la base di un’economia a favore dei produttori, destinata a essere l’impopolare filosofia borghese della classe dominante presso la maggioranza marxista; quella proposta da Menger era in realtà un’economia dei consumatori, in cui essi stabiliscono il valore delle produzioni e muovono le forze materiali della società.
Sarà Hayek a fondare una nuova visione totale del mondo nel suo approccio prasseologico, recuperando l’intuizione della tradizione liberale inglese che l’azione umana forma le istituzioni sociali grazie alle sue conseguenze non intenzionali. Così liberismo e liberalismo diventano conseguenze logiche di tutta quella sfera della vita pratica e privata dell’uomo, dell’etica e della spiritualità. Benché Hayek stesso fosse ateo, volle contrastare l’individualismo liberalista di matrice nichilista e utilitarista, che voleva portare il soggettivismo dei valori a prova del relativismo. Al contrario, l’autore si appresta a ricostruire la tradizione europea di un vero individualismo, che parte dal personalismo cristiano fino alla Scuola di Salamanca e al pensiero di Lord Acton. La religione in sé ha avuto, in quando ordine spontaneo delle azioni umane, il ruolo di portare l’Occidente alla mentalità individualista in cui è potuta germogliare l’economia di mercato. La politica e la società non possono mai porsi a controllo della religiosità individuale, in quanto ingrediente fondamentale della società stessa: le credenze religiose hanno avuto effetti inaspettati su larga scala, che possono essere positivi o negativi, così come ogni azione umana e ogni pulsione naturale hanno sempre conseguenze non intenzionali.
Per ordinare il libro di Raimondo Cubeddu:
Individualismo e religione nella scuola austriaca
È possibile visionare l’intera conferenza presso la pagina Facebook ufficiale Students For Liberty Svizzera Italiana.
Articolo su catt.ch del 16 novembre 2019
Resti sempre aggiornato sulle ultime novità
Riceva informazioni sulle pubblicazioni e sugli eventi più attuali circa una volta al mese.
L’Istituto Liberale riceve volentieri i Suoi messaggi.
LIBERALES INSTITUT
Hochstrasse 38
8044 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Riceverà circa una volta al mese informazioni sulle pubblicazioni e gli eventi più recenti