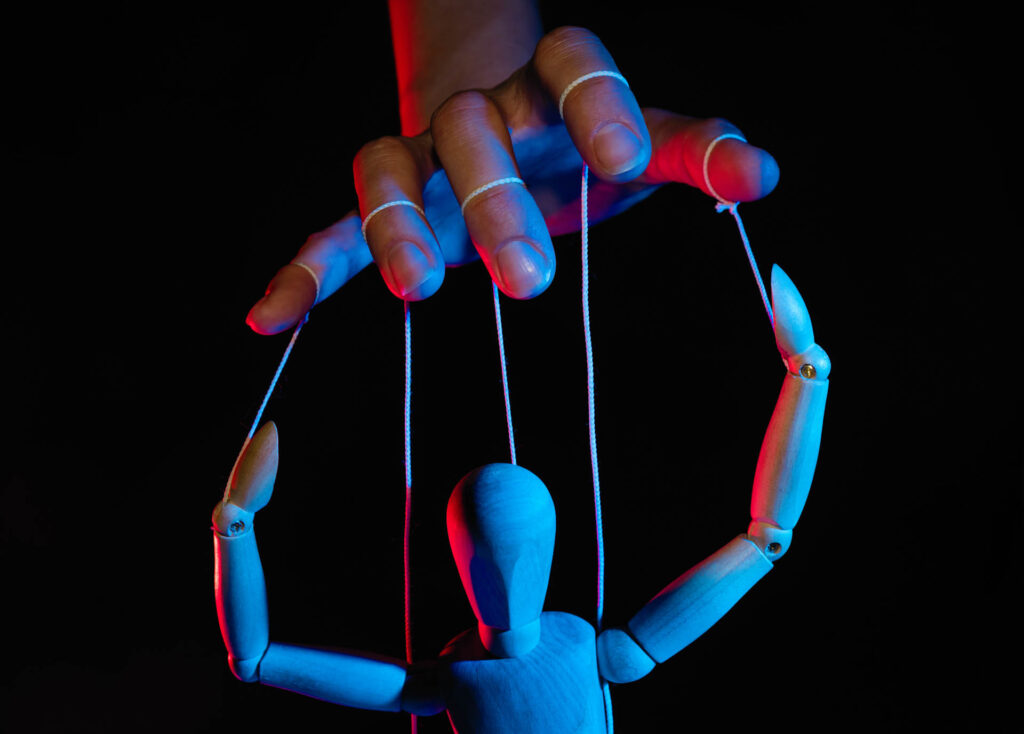
Nel dibattito pubblico spesso ci s’interroga su quali possano essere le qualità necessarie a un politico: a chi si candida a rappresentare i concittadini e ad assumere decisioni che riguardano la società nel suo insieme. In questa discussione si sottolinea a più riprese, anche in Ticino, come sia importante possedere una formazione scolastica di qualità, avere alle spalle specifiche esperienze lavorative e/o associative, possedere determinate competenze.
Questo sembra ovvio, ma le questioni sono meno semplici di quanto appaiano. In effetti, quando iniziò ad affermarsi la logica della rappresentanza (intesa come “delega”) l’idea era che il mandatario fosse essenzialmente un portatore di opinioni, e non già un soggetto con specifiche conoscenze. D’altra parte, in che modo un deputato potrebbe esprimersi in maniera appropriata al tempo stesso su questioni di finanza, bioetica, relazioni internazionali, politica monetaria, organizzazione politica, sanità, educazione e altro ancora?
Per come era pensata nei decenni scorsi, la democrazia veniva intesa come il luogo in cui ognuno formulava le proprie idee: prescindendo da studi fatti e conoscenze tecniche. La stessa regola “one man, on vote” in fondo rinvia a questo. Se non fosse così, dovrebbero votare soltanto quanti hanno taluni titoli di studio. La scheda elettorale serviva a premiare questa o quella visione generale, che poi doveva essere tradotta in azione da un apparato tecnico (i funzionari di Stato) che era pensato come neutrale rispetto ai valori e disposto a mettersi al servizio di qualsiasi indirizzo politico: conservatore, progressista o altro ancora.
In quegli schemi c’era molta ingenuità: specie dove non si vedeva che la burocrazia pubblica si presenta come “serva”, e cioè al servizio della politica, ma tende poi in varie circostanze a farsi “padrona”. Va però riconosciuto quanto meno che quella visione difendeva la tesi che il gioco democratico si basi essenzialmente sul confronto delle convinzioni e non sul prevalere delle competenze, ed è per questo che il voto di un premio Nobel vale come quello di un normale cittadino.
Per quale motivo oggi si presta invece tanta attenzione al bagaglio culturale di quanti intendono entrare in politica? Per quale ragione, in altre parole, i nostri regimi politici tendono a farsi un po’ meno “democratici” e un po’ più “tecnocratici”, dato che sempre meno chiediamo agli eletti di interpretare le nostre opinioni e sempre più di amministrarci in maniera efficace?
Se gli schemi originari del confronto democratico sono in crisi questo si deve a una serie di fattori.
In varie realtà europee, ad esempio, abbiamo sempre meno partiti culturalmente definiti (quali erano i conservatori oppure i socialisti) e sempre più formazioni legate a un leader oppure a una battaglia specifica: si pensi alla Francia di Macron o all’Italia di Berlusconi, della Lega e dei Cinquestelle. Se votiamo il partito socialista oppure quello conservatore, nel 90% dei casi possiamo prevedere come l’eletto si comporterà di fronte a questo o quel tema (ed egli sceglierà come avremmo scelto noi). Questo però non è più vero quando abbiamo formazioni post-ideologiche.
Va aggiunto che un certo declino dell’autonomia della politica è riconoscibile pure in quei Paesi in cui i partiti di matrice ottocentesca continuano a dominare la scena. Il discredito delle culture politiche, insomma, s’accompagna all’imporsi di una logica strumentale, efficientistica, sostanzialmente tecnocratica. Al centro della politica non ci sono più i grandi principi che un tempo la caratterizzavano (libertà, eguaglianza, solidarietà o altro), ma c’è invece l’illusione che vi sia una qualche soluzione corretta: che deve essere adottata in quanto efficiente.
Questo spiega il successo — anche mediatico — di una serie di figure: dal giurista all’economista, dal medico all’ingegnere. È però difficile che, in tali circostanze, lo spirito autentico della democrazia possa sopravvivere a lungo.
Carlo Lottieri è il presidente della sezione italofona dell’Istituto Liberale.
Resti sempre aggiornato sulle ultime novità
Riceva informazioni sulle pubblicazioni e sugli eventi più attuali circa una volta al mese.
L’Istituto Liberale riceve volentieri i Suoi messaggi.
LIBERALES INSTITUT
Hochstrasse 38
8044 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Riceverà circa una volta al mese informazioni sulle pubblicazioni e gli eventi più recenti